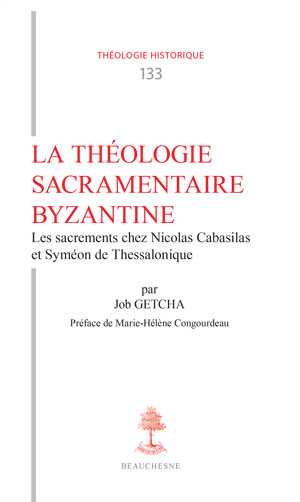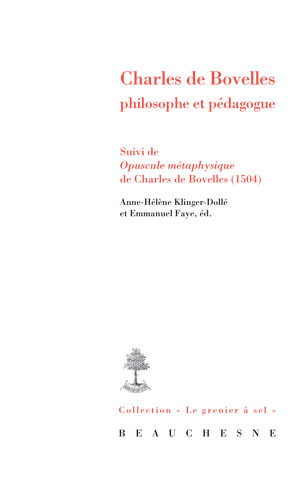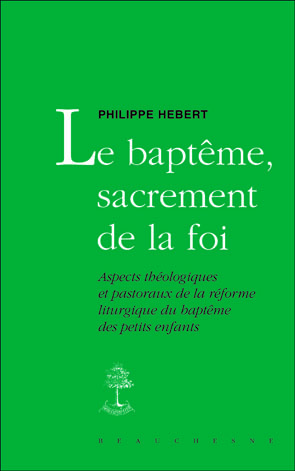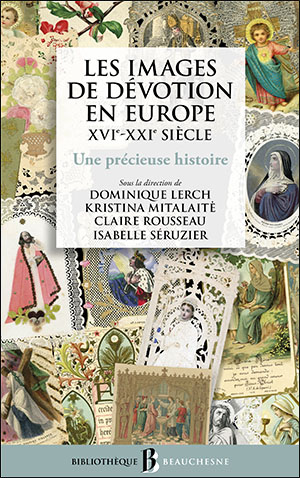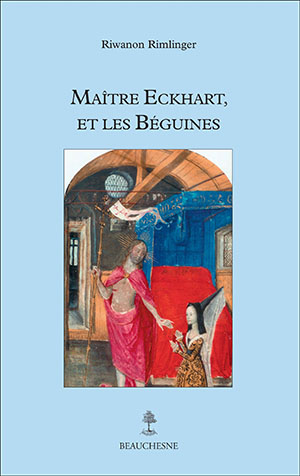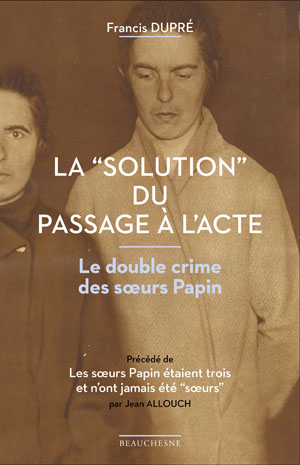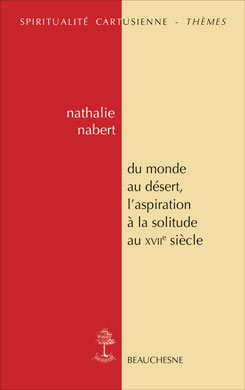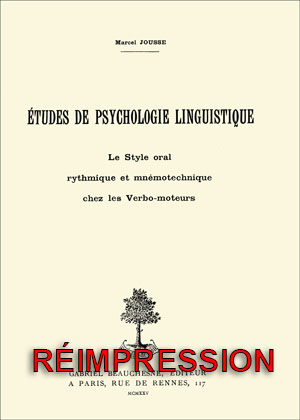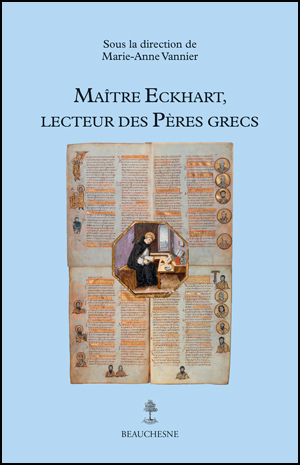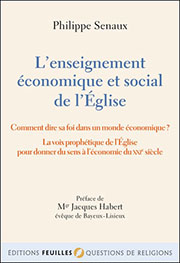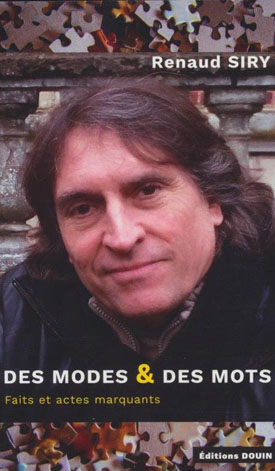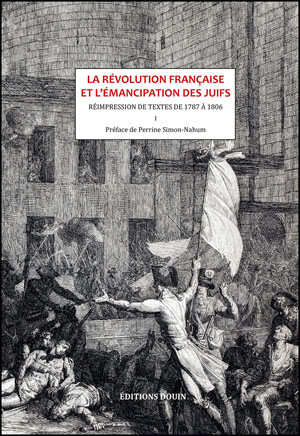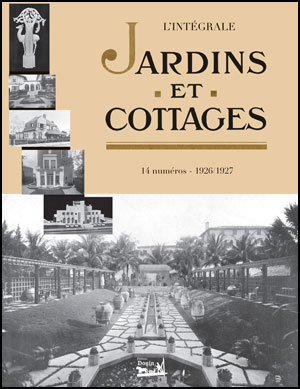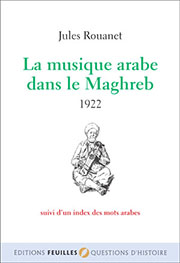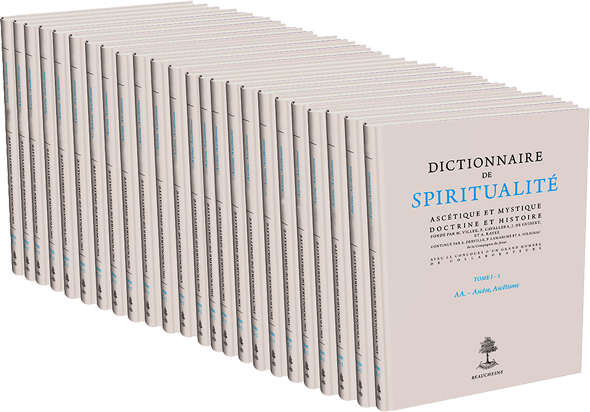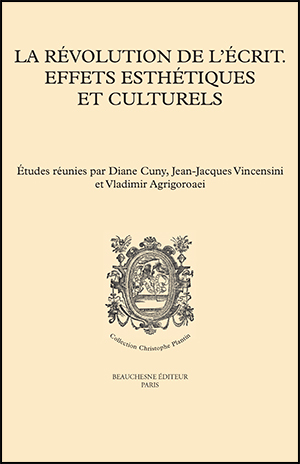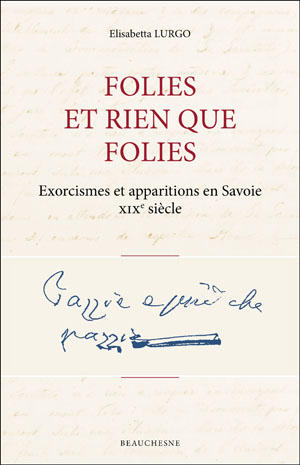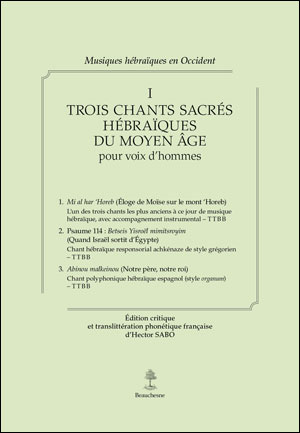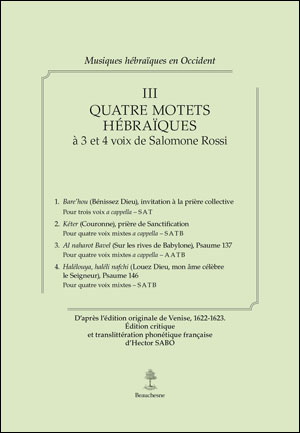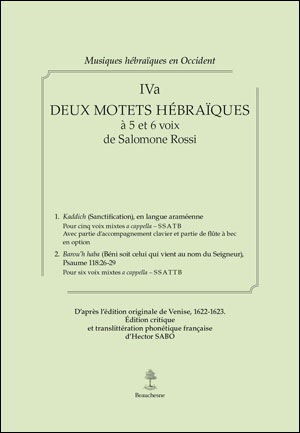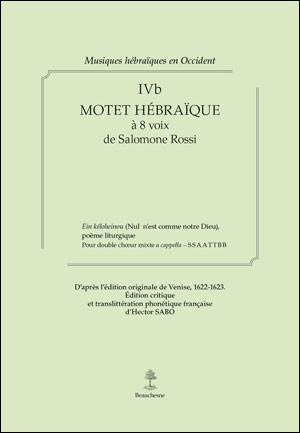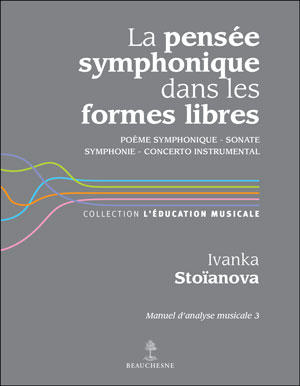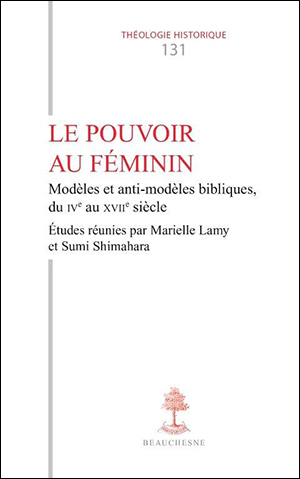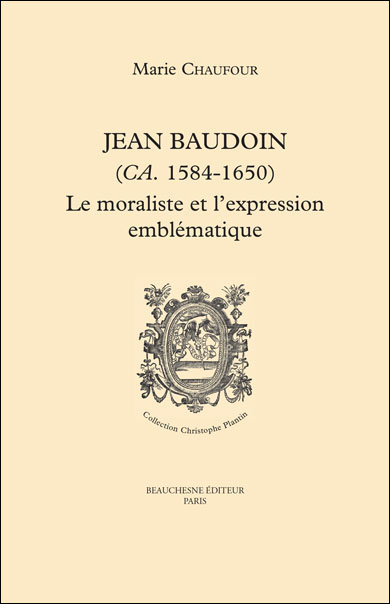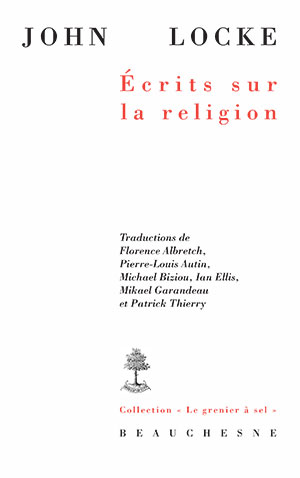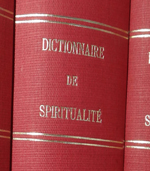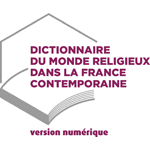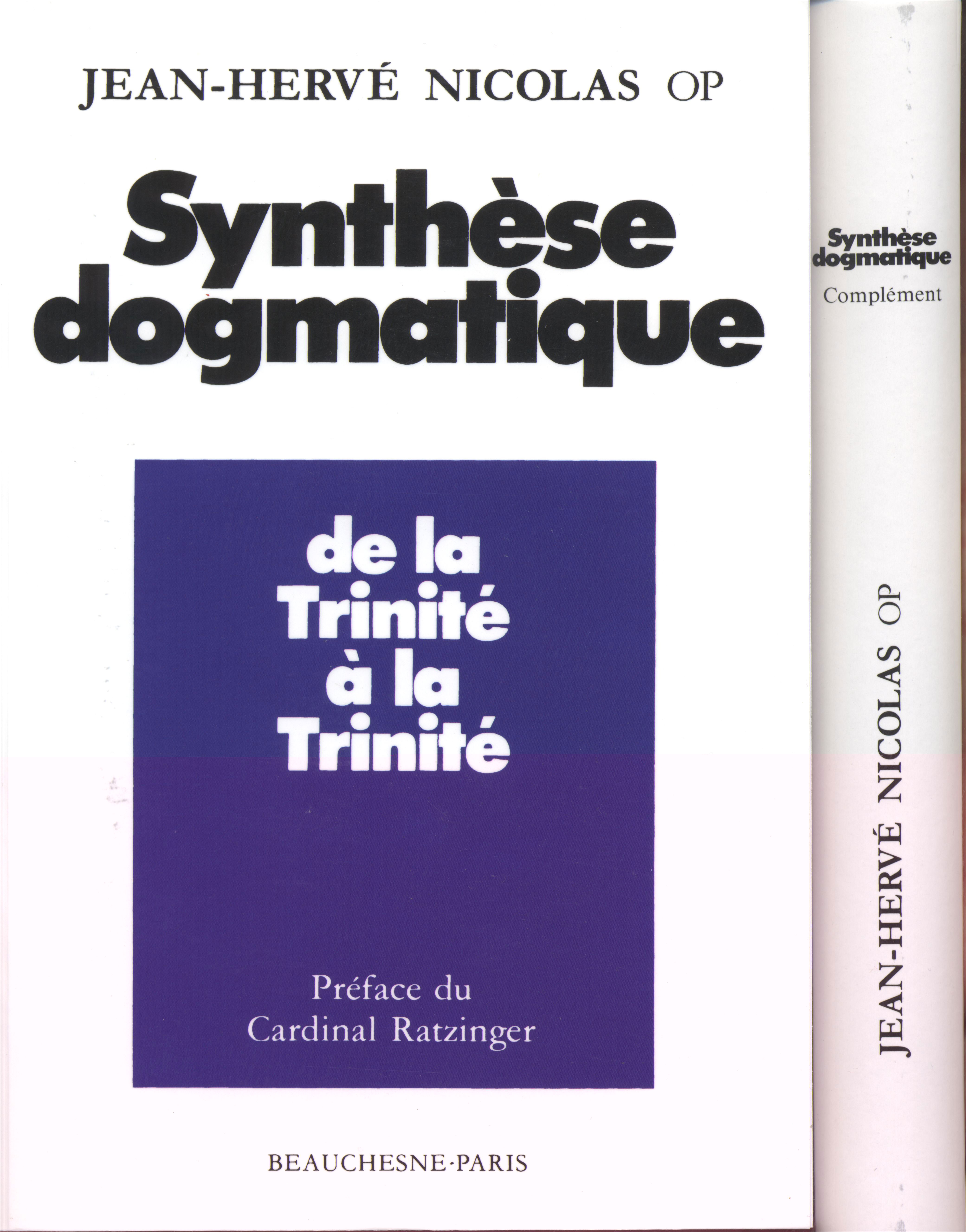45.00 €
TH n°109 MONACHISME ET ÉGLISE. LE MONACHISME SYRIEN DU IVè AU VIIè SIÈCLE : UN MONACHISME CHARISMATIQUE
Date d'ajout : mercredi 19 août 2015
par Sabino CHIALA
Lo studio di Philippe Escolan, che prende in considerazione alcune problematiche relative all' ascetismo siriaco tra il IV e il VII secolo, si inserisce all'interno di una ormai cospicua serie di ricerche che hanno contribuito a delineare il fenomeno ascetico siriaco nella sua originale fisionomia che lo differenzia dal coevo monachesimo egiziano e gli rivendica quell'origine autoctona che gli spetta. Dallo studio pionieristico di Arthur V66bus, il cui primo volume vide la luce nel 1958 (A history of Asceticism in the Syrian Orient, I-III, Louvain 1958, 1960 e 1988), al più recente Ihidayutha di Shafiq AbouZayd (Ihidayutha. A Study of the Life of Singleness in the Syrian Orient. From Ignatius of Antioch to Chalcedon 451 A.D., Oxford 1993), che si limita ai primi cinque secoli dell'era cristiana, e passando per vari articoli di Fiey riguardanti l'aspetto storico-geografico e di Brock per quello terminologico, varie ipotesi sono state formulate e poi corrette, soprattutto relativamente al periodo delle origini e in merito al complesso fenomeno dei « figli del patto », dove ancora molto resta da indagare e da chiarire, anche circa la stessa terminologia per cui la maggior parte degli studiosi è orientata ad evitare la dizione "monachesimo" per l'epoca più antica, preferendole un più generico "ascetismo".
Il passare degli anni ha visto accrescersi, con edizioni e analisi delle fonti, il materiale necessario agli storici nel loro tentativo di ricostruire le linee essenziali di questo fenomeno così complesso che è l'ascetismo siriaco ; fenomeno che nasce e si sviluppa in un'area di frontiera e in un crocevia di culture e religioni com'è la Siria-Mesopotamia, dove il mondo semitico ebraico si incontra con quello anch'esso semitico, ma aramaico-cristiano, e quest'ultimo si confronta e coesiste con l'altro mondo cristiano, quello di lingua e di cultura greca, e più tardi con il mondo arabo, cristiano e islamico. Passi sono stati fatti nell'edizione e nello studio puntuale delle fonti, e quindi ben vengano i contributi come quello di Escolan, ma molto resta ancora da fare. Se si eccettuano, infatti, le fonti greche, tra cui primeggia la Storia dei monaci di Siria di Teodoreto di Ciro abbondantemente utilizzata da Escolan e prima di lui da P. Canivet (Le monachisme syrien selon Théodoret de Cyr, Paris 1977), è ancora insoddisfacente l'attenzione riservata ai singoli "storici" antichi del monachesimo, soprattutto quelli le cui opere sono ttadite in siriaco e arabo, e alle fisionomie stesse di "asceti" (di cui ci sono pervenuti scritti o vite) e di "centri monastici". Individuati i punti principali di articolazione del movimento ascetico siriaco, sarebbero ora necessari studi puntuali su alcune figure (un esempio egregio è quello realizzato da R Beulay con la sua monografia su Giovanni di Dalyatha : L'Enseignement spirituel de Jean de Dalyatha. Mystique syro-oriental du VIIIe siècle, Paris 1990) e su movimenti concreti (si pensi ad esempio per i siro-orientali al movimento di riforma intrapreso da Abramo di Kashkar con le sue Regole), limitati nel tempo e nello spazio; basi su cui, in un futuro che speriamo non troppo lontano, si potrà tentare un nuovo approfondimento e una nuova sintesi del fenomeno globale_
Ciò premesso, lo studio di Escolan, che non si presenta propriamente come una "storia" dell'ascetismo siriaco nei secoli IV-VII ma piuttosto come un approccio originale ad alcuni suoi aspetti, risulta pregevole soprattutto per la sua capacità di mettere in discussione, talora in maniera convincente talaltra in maniera discutibile, alcune letture ritenute ormai "tradizionali" e nello stesso tempo di attirare l'attenzione, già a partire dall'introduzione, su particolari che meritano di essere sottolineati: l'aspetto "violento" o "eccessivo" dell'ascesi dell' area siriaca a proposito della quale l'autore afferma che sarebbe « dangereux de gommer les excès en ne présentant que les expériences monastiques les moins dérangeantes pour l'esprit moderne » e continua dicendo di voler prendere in considerazione « la réalité de l'excès ascétique » (pp. 1-2); il fatto che il monachesimo si concepisca o sia concepito come avente « une logique propre » che costituirebbe « un contre-modèle face à l'Église séculière, institutionelle », insomma una vera e propria realtà marginale e di più « une sorte d'excroissance » (p. 3), lo stretto legame esistente, come conseguenza di quanto appena affermato, tra l'ascesi e l'eresia; tutto ciò però non fa dell'asceta siriaco un "isolato", anzi -sottolinea Escolan - la storia mostra che « le moine syrien ne peut se résoudre à vivre totalement à l'écart du monde : c'est bien là sa grande caractéristique ! » (p. 6). È un marginale al limite e spesso confuso con l'eresia, ma che accanto alla Chiesa "istituzionale" costituisce una sorta di secondo polo necessario alla vita dei fedeli al punto che - sintetizzando il pensiero di Escolan - si potrebbe dire che da una parte c'è la Chiesa istituzionale che "media la salvezza" tramite i sacramenti e dall' altra c' è l'asceta la cui stessa vita, fatta anche di parole e gesti terapeutici, è per i fedeli strumento di salvezza. Si comprende allora il titolo programmatico e sintetico dell'opera di Escolan: « Monachisme et Eglise ».
Nel primo capitolo, dedicato al più antico ascetismo siriaco, Escolan rivisita alcune ipotesi già note, suggerendo spesso riletture abbastanza radicali, come quando critica l'idea secondo cui l'ascetismo sarebbe una nuova forma di martirio sostituitasi al martirio di sangue quando questo, per ragioni politiche, sarebbe venuto a cessare. L'autore sottolinea - a ragione - che in molti casi forme ascetiche sono concomitanti alle persecuzioni; e a questo si potrebbe aggiungere che la tesi "tradizionale", più o meno valida per il mondo greco-bizantino, risulta poi poco convincente per l'area siro-orientale che non ha mai fatto, in tutta la sua storia, esperienza del "regime di cristianità", ma che ha spesso conosciuto persecuzioni e martiri e insieme un fiorente movimento monastico_ Detto questo, va però rilevato che, sebbene non si possa parlare di avvicendamento storico tra martirio e monachesimo, è vero che nella lettura teologica del fenomeno ascetico, l'immagine del martirio di sangue ha avuto un ruolo determinante: la vita ascetica per molti autori (si veda ad esempio Isacco di Ninive) è un "altro" martirio. Martirio e ascetismo hanno in sé una medesima componente di opposizione risoluta alla "mondanità" che li accomuna sia in regime di persecuzione, sia in regime di cristianità, dove ad essere perseguitati saranno gli "eretici" cioè quanti non seguono la teologia sostenuta dall'imperatore, spesso monaci. È dunque vero che l'istanza ascetica, e le forme in cui essa si incarna, nascono, almeno in ambito siriaco, insieme alla Chiesa, come un'espressione tra le più elevate di radicalismo evangelico che ha nel celibato, così centrale nelle più antiche comunità siriache, uno degli elementi caratterizzanti. Ma a questo va aggiunto che l'opposizione alla grande Chiesa posta all'interno dei confini dell'impero bizantino, ripetutamente sottolineata da Escolan, si radicalizza man mano che le gerarchie assumono un ruolo istituzionale all'interno dell'apparato imperiale; e per contro (e andrebbe rilevato con più chiarezza), in ambito siro-orientale, l'opposizione tra movimento ascetico e Chiesa gerarchica sarà molto meno accentuata. Al tema dell'opposizione, l'autore dedica diverse pagine del primo capitolo, dove afferma che « hérésie et monachisme peuvent être compris comme deux options parallèles, qui ont cette caractéristique en commun de s'opposer d'une manière ou d'une autre à l'Église établie » (p. 27). L'ascesi si concepisce tuttavia come un movimento "interno" alla realtà ecclesiale, pur nella sua diversità e marginalità rispetto all'elemento gerarchico. Parlando poi di "eresia" sorge il problema di quanto per i primi secoli, e all'interno della tradizione cristiana siriaca in particolare, si possa parlare di "Chiesa" da una parte e di movimenti ereticali dall'altra: non si tratta di un'unità che si disgrega, ma di diversità - si ha spesso l'impressione - che si agglomerano_ Forse quella varietà costitutiva del movimento ascetico siriaco è anche un riflesso di tale situazione ecclesiale; e quindi - conclude Escolan alla fine del primo capitolo - poco noi conosciamo del primo ascetismo siriaco, e del momento di passaggio da queste forme a ciò che più comunemente è detto "monachesimo", come poco conosciamo della Chiesa siriaca del III-IV secolo; tuttavia tre elementi gli sembrano acquisiti: « l'ascétisme dans l'Église, la faible séparation du monde, l'encratisme farniliah » (p. 69).
I capitoli secondo e terzo sono dedicati ancora al tema delle eresie e alloro raffronto con l'ascetismo. Il capitolo secondo si apre con un'affermazione molto netta: « En Syrie, l'hérésie est presque systématiquement ascétique » (p. 71). Fatta qualche eccezione o precisazione, questa somiglianza estrema e connivenza quasi tra eresia e ascetismo è la tesi che l'intero capitolo tenta di dimostrare. Verso la fine Escolan dice : « Les moines, pour Chrysostome, sont donc, au meme titre que les hérétiques, les héritiers du premier christianisme » (p. 87) ; la differenza sarebbe che mentre le eresie sono rigettate, il monachesimo è tollerato dalla Chiesa ufficiale. Come l'eresia rispecchierebbe, in un certo senso anche nella struttura (p. 90), la Chiesa primitiva, così anche l'ascetismo sarebbe un continuo insorgere e permanere delle istanze evangeliche radicali. L'autore concede tuttavia che all'interno dell'ascetismo "tollerato" dalla grande Chiesa vi sia spesso anche una lotta agli eccessi, che si concepisce come lotta all' eresia : si tratta di celibi che spesso si trovano a difendere dai denigratori encratiti la positività dell'unione coniugale ; di digiunatori che insegnano in funzione anti-dualistica, la bontà dei cibi da Dio donati agli uomini e della creazione intera. A titolo esemplificativo, e anche a motivo dell'importanza che esso riveste nel mondo siriaco, l'autore prende quindi in considerazione (capitolo m) il "Messalianesimo" che egli qualifica come « de mouvement héterodoxe syrien le plus influent » e un « ascétisme dissident… alternative séduisante au monachisme classique » (p. 91). L'impostazione di Escolan presuppone una lettura piuttosto compatta del fenomeno, mentre sembra preferibile vederlo piuttosto come una tendenza o un insieme di fenomeni paralleli, ma indipendenti, accomunati semplicemente da un rigorismo che pesso ha nella tendenza all' encratismo il suo elemento più vistoso e si risolve poi in una serie di atteggiamenti di disprezzo del corpo, del cibo, della Chiesa istituzionale… E al centro del capitolo Escolan individua anche quelli che egli chiama « les trois éléments fondamentaux de la théologie messalienne », cioè : « l'inhabitation de Satan, son remplacement par l'Esprit, et le rôlee de l'ascétisme dans ce changement de la personne humaine » (p. 95),
I capitoli quarto e quinto sono dedicati a due aspetti particolari del movimento ascetico: l'accesso alla vita monastica, ove l'autore si dilunga - dando forse un po' troppo credito alla letteratura agiografica - sul fenomeno dei bambini "offerti" ai monasteri perché avuti in seguito a un voto (è il caso dello stesso Teodoreto di Ciro); e poi il problema delle risorse economiche degli asceti. Diversamente da quello egiziano, nel monachesimo siriaco si nota come il lavoro sia tenuto in scarsa considerazione; effettivamente sono pochi gli autori ascetici che difendono l'importanza del lavoro. Si sviluppa quindi anche un valore soteriologico accordato all'elemosina che i laici fanno agli asceti, parallelamente a quanto accade per l'elemosina fatta ai poveri.
Quindi l'autore passa ad analizzare (capitolo VI) alcuni aspetti del rapporto tra asceti e laici. Gli asceti di Siria e Mesopotarnia si distinguono - e qui è un altro elemento originale rispetto all'Egitto - per la loro attività evangelizzatrice, rivolta a cristiani e pagani. Perfino gli stiliti - si pensi a quanto Teodoreto dice di Simeone - sono, dall'alto delle loro colonne, predicatori infaticabili; e se dalla Siria si va alla Mesopotamia, si nota come i monasteri siano spesso sede di vere e proprie scuole dedite all' alfabetizzazione o alla formazione teologica di preti e vescovi.
Nei capitoli settimo e ottavo il tema è ancora quello del rapporto tra ascetismo e Chiesa che si rivela, in maniera contraddittoria, da un lato come rifiuto da parte degli asceti dell'ordinazione presbiterale o episcopale, e dall' altro come « mainrnise » dei monaci sull' episcopato. Circa il rifiuto delle cariche ecclesiastiche, attestato anche in Egitto, è celebre la vicenda di Macedonio che attratto con l'inganno dal vescovo di Antiochia, è ordinato a propria insaputa e senza che se ne accorga; quando alla fine della celebrazione qualcuno gli spiega l'accaduto, Macedonio ha verso il vescovo una reazione piuttosto irriverente (pp. 278-279). Parallelamente è attestato un rapporto particolare con le realtà sacramentali: Simeone il Giovane, che celebra una liturgia mentre non è ancora stato ordinato dalla gerarchia (p. 274), e Giuseppe di Bet Qoqa del quale si narra che non andava mai alla sinassi, e come lui sono diversi gli asceti che solo raramente partecipano alla celebrazione eucaristica (pp. 296-297). Si nota dunque una certa reticenza che non è specificatamente indirizzata alle « realtà sacramentali », ma che attraverso di esse - secondo Escolan - mirerebbe ad affermare l'indipendenza del fenomeno ascetico dalle autorità ecclesiastiche, essendo il sacerdozio, con tutto ciò che gli è connesso, una delle vie per cui l'autorità controllerebbe « la société monastique » (p. 309), per cui « la vrai raison de l'ordination des moines est pratique et ecclésiologique » (p. 310). All'opposto, ma come « suite logique » (p. 313) di tutto ciò, si trova l'altro aspetto del rapporto tra ascetismo e vita della Chiesa, cioè la scelta dei vescovi tra i monaci. Ancora di un aspetto di "integrazione" dei monaci nelle vicende della Chiesa si tratta al capitolo nono : la partecipazione degli asceti ai conflitti ecclesiastici. Spesso i vescovi trovano nei monasteri truppe scelte per intervenire contro pagani, ebrei ed eretici. E questi ultimi non mancano certo di energie e anche di fantasia nel venire in loro soccorso !
Il rapporto tra autorità ecclesiastica e movimento ascetico, intorno a cui si muove l'intero studio di Escolan, si rivela dunque come una sorta di antagonismo continuo e nello stesso tempo di complicità.
Il libro ha il grande pregio di suscitare la riflessione; alcune sue posizioni - a volte forse troppo nette - fanno riflettere e invitano a rileggere il movimento ascetico con occhi nuovi e critici, benché alcune delle soluzioni presentate dall'autore meritino ulteriori approfondimenti e verifiche, magari a partire da una base documentaria più ampia di quella da lui utilizzata. Per concludere, Ùe rilievi più puntuali che nulla tolgono al pregio dell'opera: si nota a volte una certa incoerenza nelle regole seguite per la traslitterazione dei termini siriaci; si vorrebbe vedere sempre meno utilizzata la terminologia confessionale, e storicamente inadeguata, di "monofisiti" (che potrebbero indicarsi con "Siro-occidentali") e "nestoriani" (ossia "Siro-orientali"); e infine, una cartina geografica potrebbe aiutare ad orientarsi nel complesso e poco noto mondo siro-mesopotamico e quindi a rendere più agevole la comprensione delle problematiche esposte.
Il passare degli anni ha visto accrescersi, con edizioni e analisi delle fonti, il materiale necessario agli storici nel loro tentativo di ricostruire le linee essenziali di questo fenomeno così complesso che è l'ascetismo siriaco ; fenomeno che nasce e si sviluppa in un'area di frontiera e in un crocevia di culture e religioni com'è la Siria-Mesopotamia, dove il mondo semitico ebraico si incontra con quello anch'esso semitico, ma aramaico-cristiano, e quest'ultimo si confronta e coesiste con l'altro mondo cristiano, quello di lingua e di cultura greca, e più tardi con il mondo arabo, cristiano e islamico. Passi sono stati fatti nell'edizione e nello studio puntuale delle fonti, e quindi ben vengano i contributi come quello di Escolan, ma molto resta ancora da fare. Se si eccettuano, infatti, le fonti greche, tra cui primeggia la Storia dei monaci di Siria di Teodoreto di Ciro abbondantemente utilizzata da Escolan e prima di lui da P. Canivet (Le monachisme syrien selon Théodoret de Cyr, Paris 1977), è ancora insoddisfacente l'attenzione riservata ai singoli "storici" antichi del monachesimo, soprattutto quelli le cui opere sono ttadite in siriaco e arabo, e alle fisionomie stesse di "asceti" (di cui ci sono pervenuti scritti o vite) e di "centri monastici". Individuati i punti principali di articolazione del movimento ascetico siriaco, sarebbero ora necessari studi puntuali su alcune figure (un esempio egregio è quello realizzato da R Beulay con la sua monografia su Giovanni di Dalyatha : L'Enseignement spirituel de Jean de Dalyatha. Mystique syro-oriental du VIIIe siècle, Paris 1990) e su movimenti concreti (si pensi ad esempio per i siro-orientali al movimento di riforma intrapreso da Abramo di Kashkar con le sue Regole), limitati nel tempo e nello spazio; basi su cui, in un futuro che speriamo non troppo lontano, si potrà tentare un nuovo approfondimento e una nuova sintesi del fenomeno globale_
Ciò premesso, lo studio di Escolan, che non si presenta propriamente come una "storia" dell'ascetismo siriaco nei secoli IV-VII ma piuttosto come un approccio originale ad alcuni suoi aspetti, risulta pregevole soprattutto per la sua capacità di mettere in discussione, talora in maniera convincente talaltra in maniera discutibile, alcune letture ritenute ormai "tradizionali" e nello stesso tempo di attirare l'attenzione, già a partire dall'introduzione, su particolari che meritano di essere sottolineati: l'aspetto "violento" o "eccessivo" dell'ascesi dell' area siriaca a proposito della quale l'autore afferma che sarebbe « dangereux de gommer les excès en ne présentant que les expériences monastiques les moins dérangeantes pour l'esprit moderne » e continua dicendo di voler prendere in considerazione « la réalité de l'excès ascétique » (pp. 1-2); il fatto che il monachesimo si concepisca o sia concepito come avente « une logique propre » che costituirebbe « un contre-modèle face à l'Église séculière, institutionelle », insomma una vera e propria realtà marginale e di più « une sorte d'excroissance » (p. 3), lo stretto legame esistente, come conseguenza di quanto appena affermato, tra l'ascesi e l'eresia; tutto ciò però non fa dell'asceta siriaco un "isolato", anzi -sottolinea Escolan - la storia mostra che « le moine syrien ne peut se résoudre à vivre totalement à l'écart du monde : c'est bien là sa grande caractéristique ! » (p. 6). È un marginale al limite e spesso confuso con l'eresia, ma che accanto alla Chiesa "istituzionale" costituisce una sorta di secondo polo necessario alla vita dei fedeli al punto che - sintetizzando il pensiero di Escolan - si potrebbe dire che da una parte c'è la Chiesa istituzionale che "media la salvezza" tramite i sacramenti e dall' altra c' è l'asceta la cui stessa vita, fatta anche di parole e gesti terapeutici, è per i fedeli strumento di salvezza. Si comprende allora il titolo programmatico e sintetico dell'opera di Escolan: « Monachisme et Eglise ».
Nel primo capitolo, dedicato al più antico ascetismo siriaco, Escolan rivisita alcune ipotesi già note, suggerendo spesso riletture abbastanza radicali, come quando critica l'idea secondo cui l'ascetismo sarebbe una nuova forma di martirio sostituitasi al martirio di sangue quando questo, per ragioni politiche, sarebbe venuto a cessare. L'autore sottolinea - a ragione - che in molti casi forme ascetiche sono concomitanti alle persecuzioni; e a questo si potrebbe aggiungere che la tesi "tradizionale", più o meno valida per il mondo greco-bizantino, risulta poi poco convincente per l'area siro-orientale che non ha mai fatto, in tutta la sua storia, esperienza del "regime di cristianità", ma che ha spesso conosciuto persecuzioni e martiri e insieme un fiorente movimento monastico_ Detto questo, va però rilevato che, sebbene non si possa parlare di avvicendamento storico tra martirio e monachesimo, è vero che nella lettura teologica del fenomeno ascetico, l'immagine del martirio di sangue ha avuto un ruolo determinante: la vita ascetica per molti autori (si veda ad esempio Isacco di Ninive) è un "altro" martirio. Martirio e ascetismo hanno in sé una medesima componente di opposizione risoluta alla "mondanità" che li accomuna sia in regime di persecuzione, sia in regime di cristianità, dove ad essere perseguitati saranno gli "eretici" cioè quanti non seguono la teologia sostenuta dall'imperatore, spesso monaci. È dunque vero che l'istanza ascetica, e le forme in cui essa si incarna, nascono, almeno in ambito siriaco, insieme alla Chiesa, come un'espressione tra le più elevate di radicalismo evangelico che ha nel celibato, così centrale nelle più antiche comunità siriache, uno degli elementi caratterizzanti. Ma a questo va aggiunto che l'opposizione alla grande Chiesa posta all'interno dei confini dell'impero bizantino, ripetutamente sottolineata da Escolan, si radicalizza man mano che le gerarchie assumono un ruolo istituzionale all'interno dell'apparato imperiale; e per contro (e andrebbe rilevato con più chiarezza), in ambito siro-orientale, l'opposizione tra movimento ascetico e Chiesa gerarchica sarà molto meno accentuata. Al tema dell'opposizione, l'autore dedica diverse pagine del primo capitolo, dove afferma che « hérésie et monachisme peuvent être compris comme deux options parallèles, qui ont cette caractéristique en commun de s'opposer d'une manière ou d'une autre à l'Église établie » (p. 27). L'ascesi si concepisce tuttavia come un movimento "interno" alla realtà ecclesiale, pur nella sua diversità e marginalità rispetto all'elemento gerarchico. Parlando poi di "eresia" sorge il problema di quanto per i primi secoli, e all'interno della tradizione cristiana siriaca in particolare, si possa parlare di "Chiesa" da una parte e di movimenti ereticali dall'altra: non si tratta di un'unità che si disgrega, ma di diversità - si ha spesso l'impressione - che si agglomerano_ Forse quella varietà costitutiva del movimento ascetico siriaco è anche un riflesso di tale situazione ecclesiale; e quindi - conclude Escolan alla fine del primo capitolo - poco noi conosciamo del primo ascetismo siriaco, e del momento di passaggio da queste forme a ciò che più comunemente è detto "monachesimo", come poco conosciamo della Chiesa siriaca del III-IV secolo; tuttavia tre elementi gli sembrano acquisiti: « l'ascétisme dans l'Église, la faible séparation du monde, l'encratisme farniliah » (p. 69).
I capitoli secondo e terzo sono dedicati ancora al tema delle eresie e alloro raffronto con l'ascetismo. Il capitolo secondo si apre con un'affermazione molto netta: « En Syrie, l'hérésie est presque systématiquement ascétique » (p. 71). Fatta qualche eccezione o precisazione, questa somiglianza estrema e connivenza quasi tra eresia e ascetismo è la tesi che l'intero capitolo tenta di dimostrare. Verso la fine Escolan dice : « Les moines, pour Chrysostome, sont donc, au meme titre que les hérétiques, les héritiers du premier christianisme » (p. 87) ; la differenza sarebbe che mentre le eresie sono rigettate, il monachesimo è tollerato dalla Chiesa ufficiale. Come l'eresia rispecchierebbe, in un certo senso anche nella struttura (p. 90), la Chiesa primitiva, così anche l'ascetismo sarebbe un continuo insorgere e permanere delle istanze evangeliche radicali. L'autore concede tuttavia che all'interno dell'ascetismo "tollerato" dalla grande Chiesa vi sia spesso anche una lotta agli eccessi, che si concepisce come lotta all' eresia : si tratta di celibi che spesso si trovano a difendere dai denigratori encratiti la positività dell'unione coniugale ; di digiunatori che insegnano in funzione anti-dualistica, la bontà dei cibi da Dio donati agli uomini e della creazione intera. A titolo esemplificativo, e anche a motivo dell'importanza che esso riveste nel mondo siriaco, l'autore prende quindi in considerazione (capitolo m) il "Messalianesimo" che egli qualifica come « de mouvement héterodoxe syrien le plus influent » e un « ascétisme dissident… alternative séduisante au monachisme classique » (p. 91). L'impostazione di Escolan presuppone una lettura piuttosto compatta del fenomeno, mentre sembra preferibile vederlo piuttosto come una tendenza o un insieme di fenomeni paralleli, ma indipendenti, accomunati semplicemente da un rigorismo che pesso ha nella tendenza all' encratismo il suo elemento più vistoso e si risolve poi in una serie di atteggiamenti di disprezzo del corpo, del cibo, della Chiesa istituzionale… E al centro del capitolo Escolan individua anche quelli che egli chiama « les trois éléments fondamentaux de la théologie messalienne », cioè : « l'inhabitation de Satan, son remplacement par l'Esprit, et le rôlee de l'ascétisme dans ce changement de la personne humaine » (p. 95),
I capitoli quarto e quinto sono dedicati a due aspetti particolari del movimento ascetico: l'accesso alla vita monastica, ove l'autore si dilunga - dando forse un po' troppo credito alla letteratura agiografica - sul fenomeno dei bambini "offerti" ai monasteri perché avuti in seguito a un voto (è il caso dello stesso Teodoreto di Ciro); e poi il problema delle risorse economiche degli asceti. Diversamente da quello egiziano, nel monachesimo siriaco si nota come il lavoro sia tenuto in scarsa considerazione; effettivamente sono pochi gli autori ascetici che difendono l'importanza del lavoro. Si sviluppa quindi anche un valore soteriologico accordato all'elemosina che i laici fanno agli asceti, parallelamente a quanto accade per l'elemosina fatta ai poveri.
Quindi l'autore passa ad analizzare (capitolo VI) alcuni aspetti del rapporto tra asceti e laici. Gli asceti di Siria e Mesopotarnia si distinguono - e qui è un altro elemento originale rispetto all'Egitto - per la loro attività evangelizzatrice, rivolta a cristiani e pagani. Perfino gli stiliti - si pensi a quanto Teodoreto dice di Simeone - sono, dall'alto delle loro colonne, predicatori infaticabili; e se dalla Siria si va alla Mesopotamia, si nota come i monasteri siano spesso sede di vere e proprie scuole dedite all' alfabetizzazione o alla formazione teologica di preti e vescovi.
Nei capitoli settimo e ottavo il tema è ancora quello del rapporto tra ascetismo e Chiesa che si rivela, in maniera contraddittoria, da un lato come rifiuto da parte degli asceti dell'ordinazione presbiterale o episcopale, e dall' altro come « mainrnise » dei monaci sull' episcopato. Circa il rifiuto delle cariche ecclesiastiche, attestato anche in Egitto, è celebre la vicenda di Macedonio che attratto con l'inganno dal vescovo di Antiochia, è ordinato a propria insaputa e senza che se ne accorga; quando alla fine della celebrazione qualcuno gli spiega l'accaduto, Macedonio ha verso il vescovo una reazione piuttosto irriverente (pp. 278-279). Parallelamente è attestato un rapporto particolare con le realtà sacramentali: Simeone il Giovane, che celebra una liturgia mentre non è ancora stato ordinato dalla gerarchia (p. 274), e Giuseppe di Bet Qoqa del quale si narra che non andava mai alla sinassi, e come lui sono diversi gli asceti che solo raramente partecipano alla celebrazione eucaristica (pp. 296-297). Si nota dunque una certa reticenza che non è specificatamente indirizzata alle « realtà sacramentali », ma che attraverso di esse - secondo Escolan - mirerebbe ad affermare l'indipendenza del fenomeno ascetico dalle autorità ecclesiastiche, essendo il sacerdozio, con tutto ciò che gli è connesso, una delle vie per cui l'autorità controllerebbe « la société monastique » (p. 309), per cui « la vrai raison de l'ordination des moines est pratique et ecclésiologique » (p. 310). All'opposto, ma come « suite logique » (p. 313) di tutto ciò, si trova l'altro aspetto del rapporto tra ascetismo e vita della Chiesa, cioè la scelta dei vescovi tra i monaci. Ancora di un aspetto di "integrazione" dei monaci nelle vicende della Chiesa si tratta al capitolo nono : la partecipazione degli asceti ai conflitti ecclesiastici. Spesso i vescovi trovano nei monasteri truppe scelte per intervenire contro pagani, ebrei ed eretici. E questi ultimi non mancano certo di energie e anche di fantasia nel venire in loro soccorso !
Il rapporto tra autorità ecclesiastica e movimento ascetico, intorno a cui si muove l'intero studio di Escolan, si rivela dunque come una sorta di antagonismo continuo e nello stesso tempo di complicità.
Il libro ha il grande pregio di suscitare la riflessione; alcune sue posizioni - a volte forse troppo nette - fanno riflettere e invitano a rileggere il movimento ascetico con occhi nuovi e critici, benché alcune delle soluzioni presentate dall'autore meritino ulteriori approfondimenti e verifiche, magari a partire da una base documentaria più ampia di quella da lui utilizzata. Per concludere, Ùe rilievi più puntuali che nulla tolgono al pregio dell'opera: si nota a volte una certa incoerenza nelle regole seguite per la traslitterazione dei termini siriaci; si vorrebbe vedere sempre meno utilizzata la terminologia confessionale, e storicamente inadeguata, di "monofisiti" (che potrebbero indicarsi con "Siro-occidentali") e "nestoriani" (ossia "Siro-orientali"); e infine, una cartina geografica potrebbe aiutare ad orientarsi nel complesso e poco noto mondo siro-mesopotamico e quindi a rendere più agevole la comprensione delle problematiche esposte.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.